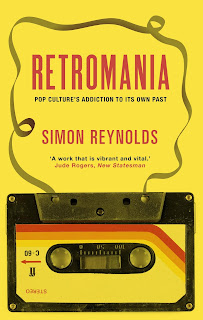L’Europa tra jazz e improvvisazione libera
“Il jazz afferma di
essere una forma d’arte. Tutta l’arte è espressione del tempo in cui ha
origine, un riflesso dell’ambiente in cui viviamo. Ecco perché un musicista
jazz europeo non dovrebbe mai suonare come un musicista nero a New York o
Chicago”
Albert Mangelsdorff
Se l’arrivo del jazz in
Europa data già dai primi anni Venti, in corrispondenza più o meno della
nascita di questa musica sul continente nordamericano, è altresì vero che fino
al secondo dopoguerra questa musica vivrà in ambiti ristretti e non avrà certo ampia
diffusione all’interno delle società europee. In Francia, in Gran Bretagna e
nella Germania di Weimar le musiche afroamericane avranno anche i loro momenti
di successo, ma ovviamente stiamo parlando di settori sociali esclusivi,
avanguardie, circoli artistici, intellettuali. Va comunque sottolineato che il
jazz, in molti casi, ricevette maggiori attenzioni ed ebbe un trattamento
migliore, da parte degli ambienti culturali europei, di quanto ne avesse avuto
negli Stati Uniti. Il primo libro sulla musica jazz è di Hugues Panassiè (“Le
Jazz Hot”), un francese amante della nuova musica afroamericana, e molti
jazzisti, quando attraversarono l’oceano per esibirsi in Europa, troveranno un
atteggiamento di assoluto rispetto, che invoglierà molti di loro a tornarci o,
in alcuni casi, a stabilirsi definitivamente.
Ostacolo alla piena diffusione
del jazz in Europa furono l’instaurarsi delle dittature fasciste e naziste, in
Italia e Germania, e delle ripercussioni che tali regimi provocarono sul resto
dei paesi del continente, così come il consolidarsi del regime staliniano
soffocò, anche qui, le sperimentazioni artistiche e il favore che il jazz, nei
primi anni dopo la rivoluzione, aveva riscosso in Russia. A parte qualche
influenza sulle musiche da ballo, del jazz non rimarrà molto fino alla Seconda
Guerra Mondiale, con l’arrivo delle truppe americane e dei loro Vdisc, dischi
espressamente registrati dalle big band per l’esercito statunitense. Se questo
vale per Italia e Germania, per quanto riguarda Francia e Gran Bretagna, la
penetrazione del jazz sarà più costante e duratura, nonostante appunto crisi
economica e venti di guerra. Django Reinhardt, chitarrista di origine rom, e il
violinista Stephan Grappelli, saranno popolari anche nella Francia del
maresciallo Petain e persino tra alcuni gerarchi nazisti, mentre il fascino del
jazz tradizionale, quello di New Orleans, manterrà solide radici in tutto il
Regno Unito, dando vita ad un grande circuito di jazz tradizionale che si
svilupperà ancor di più dopo la Guerra.
Il peso degli USA, non
solo economico ma anche culturale, condizionerà l’Europa occidentale dopo il
1945, dando vita al modello politico e sociale delle democrazie occidentali, in
netta contrapposizione con il blocco sovietico, e questo comporterà, fino al
1989, una netta divisione del continente che solo marginalmente verrà scalfita
dai movimenti artistici. Il jazz sarà un elemento fondamentale della
penetrazione culturale americana e diverrà velocemente una musica di
riferimento non solo per i musicisti professionisti e dilettanti, ma anche per
laghi settori della popolazione europea. Il ballo fece da traino ai ritmi delle
big band e, anche se in patria il movimento era in netta crisi travolto
dall’esplosione del be bop, lo swing sarà sinonimo di jazz nell’Europa degli
anni Cinquanta. Ma presto le nuove tendenze presero piede anche nel vecchio
continente, grazie ancora una volta ai numerosi concerti di musicisti americani
in Scandinavia, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Germania e la stessa
Italia. Questo comportò un consistente sviluppo del jazz europeo, con musicisti
di assoluto valore, valga l’esempio degli svedesi Lars Gullin e Arne Dohnerus, oppure
degli inglesi Ronnie Scott e Stan Tracey o del contrabbassista danese Niels-Henning
Orsted Pedersen, che pur posizionandosi su un terreno di emulazione degli
stilemi afroamericani, tra bop e cool, grazie alle loro capacità avranno la
concreta possibilità di suonare accanto ai musicisti americani. Tuttavia, nonostante
difficoltà e ritardi, tra revival del jazz tradizionale, emulazioni e musica di
intrattenimento, l’esplosione del free jazz negli Stati Uniti non tardò molto ad
avere ripercussioni anche in Europa. Il nuovo linguaggio permise a tutta una
schiera di giovani jazzisti europei di poter approcciare finalmente la materia in
modo originale e non seguendo semplicemente le tracce dei musicisti americani.
Quell’approccio libero, creativo, fu la scintilla per far esplodere
definitivamente la scena europea, questa volta su posizioni innovative, dando
vita ad un movimento che travalicò le frontiere pur mantenendo alcune
specificità nazionali. Un primo elemento di distinzione fu, in molti casi, la
contaminazione con la musica colta, con le pratiche aleatorie e improvvisative
dei compositori americani quali Cage, Feldman, Wolff, soprattutto in Gran
Bretagna ma anche in Italia. Giorgio Gaslini e la sua musica totale, o il
Gruppo Romano Free Jazz, sono mirabili esempi di creazione di un nuovo
linguaggio che al suo interno contiene spunti, suggestioni ed elementi di
ambedue i mondi sonori, quello accademico e quello jazz. Ma anche le esperienze
inglesi del Joseph Holbrooke Trio, oppure dello Spontaneous Music Ensemble intrattengono
forti contatti e pratiche con l’aleatorietà e l’improvvisazione colta. Lo
stesso si può dire per la scena tedesca, mentre per quanto riguarda i Paesi
Bassi, qui c’è un uso più irriverente e giocoso degli stilemi jazz intrecciati all’improvvisazione
libera, con sviluppi alquanto originali. Altre caratteristiche sono le pratiche
collettive, la formazione di orchestre più o meno stabili e transnazionali come
la Globe Unity Orchestra di Schlippenbach, l’Instant Composer Pool di Misha Mengelberg,
gli ensemble di Mike Westbrook e la London Jazz Composers’Orchestra, il Willem
Breuker Kollektif. Ma anche Centipede, doppio album registrato da ben cinquanta
musicisti inglesi, tra jazz, rock e improvvisazione libera, le etichette
indipendenti come la Incus di Derek Bailey ed Evan Parker, oppure la tedesca
FMP, i concerti autogestiti e i circuiti alternativi. E certo non potevano
mancare i contatti con il nuovo rock, soprattutto in Inghilterra, così come
forte fu l’influenza dei musicisti sudafricani che aprirono il jazz inglese
alla ritmicità, agli intrecci tematici. Altrettanto importante fu il rapporto
con le musiche tradizionali, sia in Italia (ad esempio Mario Schiano e il suo
bel disco “Sud”), che in Scandinavia, dove peraltro operò con successo anche George
Russell, influenzando profondamente la scena di quei luoghi. Ma va detto che molti
musicisti americani si stabilirono, in quegli anni, spesso in Europa, dando nuova
linfa ma anche ricevendone altrettanta, alla scena europea. Steve Lacy, Don
Cherry, l’Art Ensemble Of Chicago, (Albert Ayler ed Eric Dolphy ebbero
importanti collaborazioni con musicisti europei) furono tra i molti che
seguirono l’esempio del vecchio Sidney Bechet, stabilitosi definitivamente in
Francia nel Secondo dopoguerra.
In conclusione, il jazz
europeo si inserì all’interno di quel vasto movimento, politico, sociale e
culturale, che negli anni Sessanta rivoluzionò le società del vecchio continente
e ne fu una delle espressioni artistiche di maggior rilievo. L’esperienza del
free jazz ha permesso la nascita di un linguaggio comune europeo improntato
alle pratiche di improvvisazione libera, quel territorio che prende spunti e
insegnamenti sia dal mondo delle musiche afroamericane che da quello della
musica contemporanea. E quest’approccio ha consentito l’emancipazione del jazz
europeo dall’estetica americana, pur non negandone certamente le influenze, ma
riuscendo a declinare la propria creatività con un linguaggio personale, ricco
e composito, variegato ma allo stesso tempo con un substrato comune, valicando
confini e cortine di ferro, ed arrivando effettivamente ad unificare, sotto la
bandiera dell’arte libera, l’Europa.