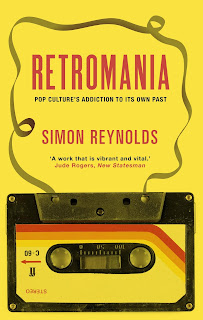Il gruppo non è certo di quelli famosi, almeno non tra il grande pubblico. E' invece stata, e lo è ancora, una di quelle formazioni di culto, venerata da un ristretto numero di fans in giro per il mondo e che con gli anni ha incrementato, seppur di poco, la propria fama.
Parliamo dei Dream Syndicate, da un paio di anni di nuovo in carreggiata, gruppo guida del Paisley Underground, quel piccolo movimento, o meglio corrente musicale, che agli inizi degli anni '80 riportò in voga la psichedelia, un certo rock grezzo, sicuramente influenzato dal punk, e un ritorno al sound chitarristico prettamente americano.
Arrivarono, Dream Syndicate, Green On Red, Rain Parade, True West, Three O' Clock, Opal, Long Ryders, Bangles, in un periodo di trionfo del sound sintetico, batterie elettroniche, tastiere, synth pop e brani dance. Con loro tornarono alla ribalta il sudore, le chitarre distorte, gli assoli e un certo rock primitivo che probabilmente non era mai andato via, semplicemente era rimasto sotto traccia, in attesa di riemergere più sporco che mai.
E agli inizi i Dream Syndicate erano veramente sporchi, così impregnati di punk ma con forti legami con il Neil Young dei Crazy Horse, la psichedelia di Nuggets, la visionarietà del Verlaine dei Television, e le atmosfere scure e inquietanti dei Velvet Underground.
Il tutto di provenienza West Coast, termine che già racchiude in sé un cumulo di suoni, atmosfere e significati tutto particolare ed alquanto caratteristico.
Steve Wynn, chitarra e voce, Karl Precoda, chitarra solista, Kendra Smith, basso, Dennis Duck, batteria, esordiscono nel 1982 con l'ep The Dream Syndicate, per poi pubblicare, sempre nello stesso anno, The Days Of Wine And Roses, loro primo lp prodotto da Chris D. dei Flesh Eaters.
Queste, fin qui, le note basilari, le informazioni primarie buone per avere un quadro, seppur sommario, della situazione.
In realtà non voglio fare un excursus critico dei lavori dei Dream Syndicate, ma affrontare particolari aspetti e curiosità.
Iniziamo dall'effettivo ruolo che hanno i membri del gruppo. La leadership è chiaramente nelle mani di Steve Wynn, cantante, frontman e autore della maggior parte dei brani. Sezione ritmica essenziale, non particolarmente brillante, poche variazioni, qualche buona linea di basso di Kendra Smith e drumming costante a supporto della musica da parte di Dennis Duck. Ma, come spesso accade nel rock, e non solo, tutto questo sembra funzionare alla perfezione con, in aggiunta e per nulla secondario in quanto a peso effettivo nel gruppo, la chitarra solista di Karl Precoda. E qui c'è il primo elemento da sottolineare. Come in tutte le storie rock che si rispettano, anche la musica dei Dream Syndicate vive e sgorga furiosa e ammaliante dall'opposizione di due personalità: quella dell'autore dei brani, del songwriter un po' sghembo ma pur sempre affidabile e alla ricerca del Nuovo Racconto Americano, e quella del folle visionario, chitarrista acido (il più acido d'America si diceva ai tempi!), irrequieto e irriducibile all'ordine, alla regolarità.
Steve Wynn e Karl Precoda sembrano incarnare le due anime del gruppo, quella psichedelica e avventurosa e quella del rock ruvido e tradizionale. In realtà, dobbiamo dirlo, in tutti e due vive la fiamma dell'irrazionale, della fuga in avanti pur ancorati alle esperienze rock del passato, elettrizzare improvvisamente la musica per poi lentamente raffreddarla in eterei fluidi cangianti. Tuttavia sono ben chiari gli approcci e i contributi di entrambi; scrittura di brani, splendide melodie con testi intriganti e distorsione degli stessi con scorribande dissonanti e incalzanti, apertura dei confini e correnti psicotiche.
Si è molto parlato, in passato, di Steve Wynn, della sua leadership e delle sue qualità come songwriter, grazie anche ad una buona carriera lontana dal gruppo. Ma, ed è qui il senso di questo post, troppo poco si è parlato della personalità di Precoda, la chitarra solista dei primi Dream Syndicate. Di chiara ispirazione hendrixiana, Karl Precoda è chitarrista anomalo, per certi versi irrispettoso e inaffidabile. C'è molto di suo nella proposta sonora dei Dream Syndicate così fresca e coinvolgente. Non si lascia irretire dalle efficaci melodie intrise di blues e roots di Wynn, non le accarezza con sagacia e virtuosismo, bensì le graffia, le assesta colpi distorti per allungarle, stirarle verso ignoti viaggi mentali e le trasforma in autentici brani psichedelici.
Il solismo di Precoda è abbastanza particolare perché di solito non segue i consueti canoni del chitarrismo rock. Non è un virtuoso ma sa dosare bene le sue capacità elaborando degli interventi musicali affatto originali, inaspettati direi. Là dove ti aspetteresti un fiume di note, un insieme di pentatoniche una dopo l'altra, lui cambia completamente strada, si incammina in territori inesplorati evocando molto con poco. E' come se dicesse, ok qui si dovrebbe fare così ma io faccio un'altra cosa, anche se al primo ascolto non vi piace. Un esempio significativo è il brano che dà il titolo al loro primo Lp, The Days Of Wine And Roses.
https://www.youtube.com/watch?v=f-_G7A0RbjU
Splendida canzone strutturata su strofe, ritornelli, brevi bridge, e poi una lunga parte centrale dove Precoda mostra le sue peculiarità di chitarrista "acido". In un brano così ti aspetteresti un assolo di chitarra pieno di fraseggi blues, e invece ci troviamo di fronte ad un lungo, estenuante e inquietante magma sonoro, fatto di rumore, brevi frasi distorte costruite sulle note basse della chitarra che si confondono con la ritmica di Wynn. Non sembra neanche essere un solo bensì una macchia sonora che emerge e poi riaffonda all'interno dello scorrere del tempo, così deforme ed allo stesso tempo originale. E poi, alla fine, una breve sequenza cromatica che finisce su un Mi ossessivo, lancinante, minimalista e inquietante, lungo, che sembra non voler finire mai e che lancia il ritorno della voce di Wynn, per concludersi in un assalto sonoro con il ritornello ripetuto più volte, sempre più urlato, sempre più sporco. Il finale, secco ed inarrivabile (con evidente errore ritmico!), lascia l'ascoltatore esausto. Si potrebbe benissimo dire: ecco, questo è Precoda. Forse nessun altro chitarrista rock avrebbe avuto il coraggio di suonare così in un brano. Molto con poco, è la sua filosofia.
Altro esempio è Until Lately, sempre sullo stesso lp, dove si produce in una linea di chitarra che fa da contrappunto alla voce di Wynn, per poi sporcare le strofe , in sottofondo, con rumori e feedback, note singole distorte e penetranti. Anche qui nel finale la chitarra esplode sotto le frasi sempre più urlate di Wynn e un'armonica a bocca che ricorda il primo blues. Il brano di apertura di The Days Of Wine And Roses è, anch'esso a suo modo, una sorta di manifesto dell'approccio per molti versi minimalista, di Precoda. Tell Me When It's Over è una splendida ballata, si potrebbe dire tipica dei Dream Syndicate. Un bel riff, una suggestiva linea melodica e poi, quando ci sarebbe tutto lo spazio per un assolo di chitarra, Precoda preferisce suonare una sola nota, ripetuta, dolce e sognante (una delle poche sovraincisioni del disco, quasi tutto suonato in diretta). Tutto qui, nient'altro. Mentre su When You Smile, autentico gioiello, l'inizio è affidato ad una serie di feedback che Precoda sembra governare con maestria, lasciando emergere con grazia il dolce arpeggio della chitarra di Wynn. A tutto questo va aggiunto il suono generale del disco: la voce vicina al Lou Reed più alienato, una generale noncuranza degli aspetti esteriori come la qualità del suono, registrazione in presa diretta, errori, ma quanta energia, quanto sudore e quanta musica. Il tono generale è sporco, ruvido, e questo esalta le caratteristiche di Precoda così come le splendide composizioni di Wynn. All'epoca si diceva ricalcassero troppo i primi Velvet Underground, ed in parte poteva essere anche vero. Ma, a differenza del gruppo newyorchese, c'è meno arte e più istintività, meno elaborazioni intellettuali e più viaggio acido.
Che succede a questo punto? Tutto sembra funzionare, almeno alle nostre orecchie, ma evidentemente non è così. L'approdo ad una grossa etichetta (A&M Records) comporta una serie di modifiche che saranno determinanti per il futuro del gruppo. Partiamo da una delle più evidenti: il cambio del produttore. Da Chris D. si passa a Sandy Pearlman, da un esponente del punk acido americano al creatore del suono Blue Oyster Cult, così perfetto, pulito, preciso. Anche con i Clash di Give 'Em Enough Rope Pearlman aveva tentato di ricondurre il punk grezzo e riottoso ad una levigata forma metallica assolutamente fuori luogo per una formazione come i Clash. E questa stessa operazione viene riproposta con The Medicine Show, secondo lp dei Dream Syndicate. Non che il suono sia lo stesso dei Clash, ma è quell'approccio ordinato, distinto, da rock adulto, che viene riproposto, scardinando di fatto quell'equilibrio sonoro raggiunto nel precedente lavoro. Ad aggiungere una patina di "serietà" viene aggregato alla formazione il pianista Tom Zvoncheck mentre al posto delle soavi linee di basso di Kendra Smith, che lascia il gruppo per formare gli Opal, arriva Dave Provost.
Non vorrei parlare troppo male di The Medicine Show perché, alla fine, è comunque un bel disco. Ma la magia di quel suono graffiante, acido, irruento, quel viaggio tra i lidi psichedelici che The Days Of Wine And Roses aveva compiuto con rara efficacia, viene deliberatamente eroso da un sound più levigato, gentile e rispettoso dei canoni del buon rock. Ed ovviamente chi ne farà più le spese sarà proprio la chitarra di Precoda, irregimentata in un suono che lascia poco spazio ai rumori, alle fantasie e alle scorribande soniche. Un esempio è il brano John Coltrane Stereo Blues, che dovrebbe in parte ricoprire il ruolo che aveva, nel precedente disco, la title track; una lunga composizione fatta di improvvisazione e viaggio psichedelico. Ecco, qui Precoda avrebbe potuto essere determinante, avrebbe dovuto esplodere con rumori, distorsioni, note lancinanti. E invece rimane timido, ordinato, quasi timoroso di sporcare il brano, e con esso l'intero disco, cosa che invece non era certo accaduta in The Days Of Wine And Roses. Da questo punto di vista è certamente meglio la out take piuttosto che la versione ufficiale presente su disco.
https://www.youtube.com/watch?v=ScO27FcpzNs
Peraltro, a fronte di questa parziale delusione, Precoda piazza uno dei suoi più begli assoli in Bullet With My Name On It, uno dei rarissimi brani da lui composto. E' uno solo melodico, struggente, che riprende la melodia del ritornello modificandola e lanciandola in alto, una sorta di Dave Gilmour acido e spostato.
Mi fermo qui, senza voler andare troppo oltre. La pubblicazione del mini lp This Is Not The New Dream Syndicate Album...Live, conferma ed accentua la tendenza di Medicine Show, con la massiccia presenza delle tastiere che accerchia e soffoca pesantemente la chitarra di Precoda, fino a renderla quasi superflua. E ovviamente, con le registrazioni per il successivo lp Out Of The Grey, si arriva all'abbandono del gruppo da parte del chitarrista. L'arrivo di Paul B. Cutler, indubbiamente più virtuosistico e abbastanza convenzionale come solista, spegne definitivamente le spinte psichedeliche e rumoriste annegandole in un ovvio suono rock abbastanza scontato. A dimostrazione dell'importanza della chitarra e del solismo di Precoda va sottolineato che anche in questo album la qualità dei brani scritti da Wynn è elevata, ma la mancanza di interventi creativi e spiazzanti, dei magma sonori e dei dardi distorti che percorrevano la musica dei Dream Syndicate porta ad un generale appiattimento musicale. Canzoni carine ma prive dell'estro sonoro del passato.
Fine. Non del gruppo certamente, che pubblicherà altri dischi, si scioglierà e poi tornerà ad incidere e suonare dal vivo, ma di un certo modo di intendere quel rock. La volontà di ripulire, di ingentilire ciò che alla fine è nato un po' sciatto, disordinato, sporco, il più delle volte porta al soffocamento delle istanze maggiormente creative, direi scomode. Ecco, forse la parola giusta per definire Precoda e la sua chitarra è questa: scomodo!
Qui sotto un paio di blog interessanti sui Dream Syndicate.
https://mrowster.wordpress.com/category/karl-precoda/
http://www.myrareguitars.com/the-dream-syndicate
pop
Steve Wynn, chitarra e voce, Karl Precoda, chitarra solista, Kendra Smith, basso, Dennis Duck, batteria, esordiscono nel 1982 con l'ep The Dream Syndicate, per poi pubblicare, sempre nello stesso anno, The Days Of Wine And Roses, loro primo lp prodotto da Chris D. dei Flesh Eaters.
Queste, fin qui, le note basilari, le informazioni primarie buone per avere un quadro, seppur sommario, della situazione.
In realtà non voglio fare un excursus critico dei lavori dei Dream Syndicate, ma affrontare particolari aspetti e curiosità.
Iniziamo dall'effettivo ruolo che hanno i membri del gruppo. La leadership è chiaramente nelle mani di Steve Wynn, cantante, frontman e autore della maggior parte dei brani. Sezione ritmica essenziale, non particolarmente brillante, poche variazioni, qualche buona linea di basso di Kendra Smith e drumming costante a supporto della musica da parte di Dennis Duck. Ma, come spesso accade nel rock, e non solo, tutto questo sembra funzionare alla perfezione con, in aggiunta e per nulla secondario in quanto a peso effettivo nel gruppo, la chitarra solista di Karl Precoda. E qui c'è il primo elemento da sottolineare. Come in tutte le storie rock che si rispettano, anche la musica dei Dream Syndicate vive e sgorga furiosa e ammaliante dall'opposizione di due personalità: quella dell'autore dei brani, del songwriter un po' sghembo ma pur sempre affidabile e alla ricerca del Nuovo Racconto Americano, e quella del folle visionario, chitarrista acido (il più acido d'America si diceva ai tempi!), irrequieto e irriducibile all'ordine, alla regolarità.
Si è molto parlato, in passato, di Steve Wynn, della sua leadership e delle sue qualità come songwriter, grazie anche ad una buona carriera lontana dal gruppo. Ma, ed è qui il senso di questo post, troppo poco si è parlato della personalità di Precoda, la chitarra solista dei primi Dream Syndicate. Di chiara ispirazione hendrixiana, Karl Precoda è chitarrista anomalo, per certi versi irrispettoso e inaffidabile. C'è molto di suo nella proposta sonora dei Dream Syndicate così fresca e coinvolgente. Non si lascia irretire dalle efficaci melodie intrise di blues e roots di Wynn, non le accarezza con sagacia e virtuosismo, bensì le graffia, le assesta colpi distorti per allungarle, stirarle verso ignoti viaggi mentali e le trasforma in autentici brani psichedelici.
Il solismo di Precoda è abbastanza particolare perché di solito non segue i consueti canoni del chitarrismo rock. Non è un virtuoso ma sa dosare bene le sue capacità elaborando degli interventi musicali affatto originali, inaspettati direi. Là dove ti aspetteresti un fiume di note, un insieme di pentatoniche una dopo l'altra, lui cambia completamente strada, si incammina in territori inesplorati evocando molto con poco. E' come se dicesse, ok qui si dovrebbe fare così ma io faccio un'altra cosa, anche se al primo ascolto non vi piace. Un esempio significativo è il brano che dà il titolo al loro primo Lp, The Days Of Wine And Roses.
https://www.youtube.com/watch?v=f-_G7A0RbjU
Splendida canzone strutturata su strofe, ritornelli, brevi bridge, e poi una lunga parte centrale dove Precoda mostra le sue peculiarità di chitarrista "acido". In un brano così ti aspetteresti un assolo di chitarra pieno di fraseggi blues, e invece ci troviamo di fronte ad un lungo, estenuante e inquietante magma sonoro, fatto di rumore, brevi frasi distorte costruite sulle note basse della chitarra che si confondono con la ritmica di Wynn. Non sembra neanche essere un solo bensì una macchia sonora che emerge e poi riaffonda all'interno dello scorrere del tempo, così deforme ed allo stesso tempo originale. E poi, alla fine, una breve sequenza cromatica che finisce su un Mi ossessivo, lancinante, minimalista e inquietante, lungo, che sembra non voler finire mai e che lancia il ritorno della voce di Wynn, per concludersi in un assalto sonoro con il ritornello ripetuto più volte, sempre più urlato, sempre più sporco. Il finale, secco ed inarrivabile (con evidente errore ritmico!), lascia l'ascoltatore esausto. Si potrebbe benissimo dire: ecco, questo è Precoda. Forse nessun altro chitarrista rock avrebbe avuto il coraggio di suonare così in un brano. Molto con poco, è la sua filosofia.
Altro esempio è Until Lately, sempre sullo stesso lp, dove si produce in una linea di chitarra che fa da contrappunto alla voce di Wynn, per poi sporcare le strofe , in sottofondo, con rumori e feedback, note singole distorte e penetranti. Anche qui nel finale la chitarra esplode sotto le frasi sempre più urlate di Wynn e un'armonica a bocca che ricorda il primo blues. Il brano di apertura di The Days Of Wine And Roses è, anch'esso a suo modo, una sorta di manifesto dell'approccio per molti versi minimalista, di Precoda. Tell Me When It's Over è una splendida ballata, si potrebbe dire tipica dei Dream Syndicate. Un bel riff, una suggestiva linea melodica e poi, quando ci sarebbe tutto lo spazio per un assolo di chitarra, Precoda preferisce suonare una sola nota, ripetuta, dolce e sognante (una delle poche sovraincisioni del disco, quasi tutto suonato in diretta). Tutto qui, nient'altro. Mentre su When You Smile, autentico gioiello, l'inizio è affidato ad una serie di feedback che Precoda sembra governare con maestria, lasciando emergere con grazia il dolce arpeggio della chitarra di Wynn. A tutto questo va aggiunto il suono generale del disco: la voce vicina al Lou Reed più alienato, una generale noncuranza degli aspetti esteriori come la qualità del suono, registrazione in presa diretta, errori, ma quanta energia, quanto sudore e quanta musica. Il tono generale è sporco, ruvido, e questo esalta le caratteristiche di Precoda così come le splendide composizioni di Wynn. All'epoca si diceva ricalcassero troppo i primi Velvet Underground, ed in parte poteva essere anche vero. Ma, a differenza del gruppo newyorchese, c'è meno arte e più istintività, meno elaborazioni intellettuali e più viaggio acido.
Che succede a questo punto? Tutto sembra funzionare, almeno alle nostre orecchie, ma evidentemente non è così. L'approdo ad una grossa etichetta (A&M Records) comporta una serie di modifiche che saranno determinanti per il futuro del gruppo. Partiamo da una delle più evidenti: il cambio del produttore. Da Chris D. si passa a Sandy Pearlman, da un esponente del punk acido americano al creatore del suono Blue Oyster Cult, così perfetto, pulito, preciso. Anche con i Clash di Give 'Em Enough Rope Pearlman aveva tentato di ricondurre il punk grezzo e riottoso ad una levigata forma metallica assolutamente fuori luogo per una formazione come i Clash. E questa stessa operazione viene riproposta con The Medicine Show, secondo lp dei Dream Syndicate. Non che il suono sia lo stesso dei Clash, ma è quell'approccio ordinato, distinto, da rock adulto, che viene riproposto, scardinando di fatto quell'equilibrio sonoro raggiunto nel precedente lavoro. Ad aggiungere una patina di "serietà" viene aggregato alla formazione il pianista Tom Zvoncheck mentre al posto delle soavi linee di basso di Kendra Smith, che lascia il gruppo per formare gli Opal, arriva Dave Provost.
Non vorrei parlare troppo male di The Medicine Show perché, alla fine, è comunque un bel disco. Ma la magia di quel suono graffiante, acido, irruento, quel viaggio tra i lidi psichedelici che The Days Of Wine And Roses aveva compiuto con rara efficacia, viene deliberatamente eroso da un sound più levigato, gentile e rispettoso dei canoni del buon rock. Ed ovviamente chi ne farà più le spese sarà proprio la chitarra di Precoda, irregimentata in un suono che lascia poco spazio ai rumori, alle fantasie e alle scorribande soniche. Un esempio è il brano John Coltrane Stereo Blues, che dovrebbe in parte ricoprire il ruolo che aveva, nel precedente disco, la title track; una lunga composizione fatta di improvvisazione e viaggio psichedelico. Ecco, qui Precoda avrebbe potuto essere determinante, avrebbe dovuto esplodere con rumori, distorsioni, note lancinanti. E invece rimane timido, ordinato, quasi timoroso di sporcare il brano, e con esso l'intero disco, cosa che invece non era certo accaduta in The Days Of Wine And Roses. Da questo punto di vista è certamente meglio la out take piuttosto che la versione ufficiale presente su disco.
https://www.youtube.com/watch?v=ScO27FcpzNs
Peraltro, a fronte di questa parziale delusione, Precoda piazza uno dei suoi più begli assoli in Bullet With My Name On It, uno dei rarissimi brani da lui composto. E' uno solo melodico, struggente, che riprende la melodia del ritornello modificandola e lanciandola in alto, una sorta di Dave Gilmour acido e spostato.
Mi fermo qui, senza voler andare troppo oltre. La pubblicazione del mini lp This Is Not The New Dream Syndicate Album...Live, conferma ed accentua la tendenza di Medicine Show, con la massiccia presenza delle tastiere che accerchia e soffoca pesantemente la chitarra di Precoda, fino a renderla quasi superflua. E ovviamente, con le registrazioni per il successivo lp Out Of The Grey, si arriva all'abbandono del gruppo da parte del chitarrista. L'arrivo di Paul B. Cutler, indubbiamente più virtuosistico e abbastanza convenzionale come solista, spegne definitivamente le spinte psichedeliche e rumoriste annegandole in un ovvio suono rock abbastanza scontato. A dimostrazione dell'importanza della chitarra e del solismo di Precoda va sottolineato che anche in questo album la qualità dei brani scritti da Wynn è elevata, ma la mancanza di interventi creativi e spiazzanti, dei magma sonori e dei dardi distorti che percorrevano la musica dei Dream Syndicate porta ad un generale appiattimento musicale. Canzoni carine ma prive dell'estro sonoro del passato.
Fine. Non del gruppo certamente, che pubblicherà altri dischi, si scioglierà e poi tornerà ad incidere e suonare dal vivo, ma di un certo modo di intendere quel rock. La volontà di ripulire, di ingentilire ciò che alla fine è nato un po' sciatto, disordinato, sporco, il più delle volte porta al soffocamento delle istanze maggiormente creative, direi scomode. Ecco, forse la parola giusta per definire Precoda e la sua chitarra è questa: scomodo!
Qui sotto un paio di blog interessanti sui Dream Syndicate.
https://mrowster.wordpress.com/category/karl-precoda/
http://www.myrareguitars.com/the-dream-syndicate
pop